Condivido il pensiero di Doyle McManus, editorialista del Los Angeles Times, espresso sul suo giornale lo scorso 16 aprile, a consuntivo dei primi cento giorni della presidenza di The Donald, che sinteticamente posso riassumere così: la rivoluzione (populista) promessa da Trump è già finita (almeno per ora).
Se da un lato, infatti, la sua teatralità scenica e la retorica oratoria sono ancora quelle consuete che abbiamo imparato a conoscere fin dalla campagna elettorale, dall’altro lato, dopo le ultime settimane, la sua politica è rientrata nel più convenzionale conservatorismo repubblicano sia in ambito economico-commerciale sia negli affari esteri.
In politica estera ha sbertucciato la Nato finché ha potuto, ha fatto l’amico di Putin presentandolo come un alleato affidabile, con continue promesse di infischiarsene della guerra civile in Siria. Poi, d’un tratto, ecco il dietro front su tutta la linea, con gli elogi per il ruolo della Nato nello scacchiere internazionale e i 59 missili Tomahawk contro la base aerea siriana autrice dei raid chimici sui “bellissimi bambini” e il relativo disappunto della Russia protettrice di Assad.
In economia ha promesso di tagliare le tasse della classe media e di proteggere “social security” e “medicare” ma il suo programma fiscale sembra andare verso direzioni diverse. Mentre a livello commerciale ha accusato la Cina di essere un “manipolatore di valuta”, ha minacciato di far saltare l’accordo di libero scambio nordamericano e ha annunciato l’abolizione della “export-import bank”. Poi, anche qui, dietro front completo.
Cosa dice Doyle McManus? Che Trump ha fatto una scoperta: fare il presidente degli USA è più complicato che vincere le elezioni.
Con ancora un’unica freccia populista al suo arco: il giro di vite sull’immigrazione clandestina negli USA, per una linea non dissimile da quella che aveva Mitt Romney, ex governatore del Massachusetts (2003-2007) e candidato repubblicano (poi sconfitto da Obama) per le presidenziali 2012.
Ed è lo stesso Lanhee Chen, consigliere di Romney nel 2012, a dire che le nuove posizioni di Trump sono in linea con quelle portate avanti da Jeb Bush, Marco Rubio e Chris Christie nel 2016. Ossia in puro “conservatorismo repubblicano convenzionale”.
Cos’è successo nella testa di Trump? si domanda McManus, dando una risposta emblematica.
“È stato aggredito dalla realtà”.
D’altronde Trump, anche durante la campagna elettorale, ha spesso rivisto le sue posizioni in funzione delle esigenze del momento, oltre al fatto, altrettanto oggettivo, che il 45esimo presidente degli Stati Uniti avesse solo una comprensione parziale – usiamo questo eufemismo – sulle reali complessità della realtà nazionale e globale.
Negli esteri, dopo la campagna all’insegna dell’“America First”, sono arrivati i dilemmi del mondo reale e Trump per ora segue il consiglio di quelli che lui chiama “i miei generali”: James N. Mattis e H.R. McMaster, rispettivamente segretario alla Difesa e consigliere alla Sicurezza nazionale.
Per questioni interne fondamentali la storia è identica. Il divieto d’ingresso negli USA verso i cittadini di alcuni paesi a maggioranza musulmana (poi rimosso per decisione di un tribunale di Washington) e il fallimento della “Trumpcare” sono stati voluti da Stephen K. Bannon, suo coordinatore della campagna elettorale e membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. E per questo motivo – oltre che per incompatibilità con il genero del presidente Jared Kushner – è stato trombato.
Adesso quindi il populismo rivoluzionario alla Bannon è “out” mentre è “in” il conservatorismo convenzionale. Ecco che McManus si pone un’altra domanda.
Allora dobbiamo aspettarci un’amministrazione Trump come fotocopia di quella promessa da Romney nel 2012?
No perché le sue posizioni continueranno a dipendere dalle esigenze del momento, nel pragmatismo dipendente dall’essere un politico sperimentale.

FORCHIELLI DELLA SERA
Più veloce della luce. La rivoluzione (populista) di Trump è già finita? Per adesso pare di sì
Alberto Forchielli2 Maggio 20170

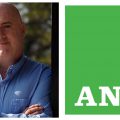

















Lascia un commento